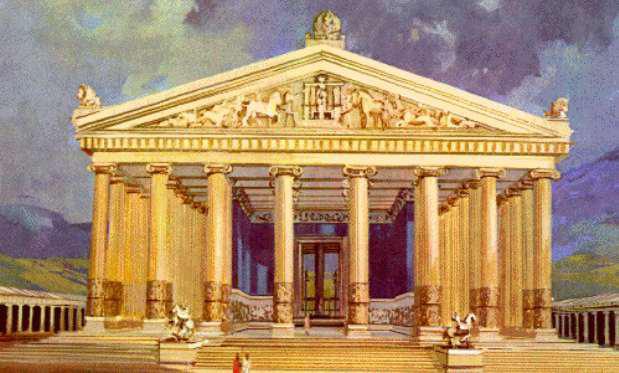Sicilia, paese di mosche e di maldicenze
Pirandello definì la Sicilia “paese di mosche e di maldicenze”. Ed era concetto esatto, anche se incompleto, perché da sempre la Sicilia è stata anche paese di pulci, pidocchi, cimici, zecche, zanzare.
Ancora una cinquantina d’anni fa, e prima dell’avvento del ddt, le giornate si passavano in compagnia delle mosche, e la sera prima di spegnere il lume o la lampada, si notavano, posate a gruppetti sui fili della corrente elettrica, sui mobili, sulle pareti, che per questo erano tappezzate di puntini neri, con le quali lasciavano il segno del loro passaggio. Si trovavano dappertutto, le mosche. Stabilmente attaccate agli occhi dei bambini, si posavano sugli escrementi animali ovunque presenti; sulle carni esposte nelle macellerie; sulle tavole imbandite dei ricchi e quelle non imbandite dei poveri, e non era raro vedere all’ora di pranzo, schiere di mosche disposte in cerchio sul bordo dei piatti colmi di brodo, a succhiare come idrovore. Ed era normale vedere uno o due di questi insetti cadere in picchiata nel liquido bollente, ora in un piatto ora in un altro, dove rimanevano stecchite e galleggianti, fino a quando un cucchiaio immerso delicatamente in superficie non recuperava il cadaverino per scagliarlo con precisione e disgusto lontano dalla tavola imbandita. Nessuno commentava l’evento, e tutti continuavano a pranzare. Insomma, si conviveva e si mangiava con le mosche. E c’erano mosche, dappertutto, a coprire i muri come carte da parati, i pavimenti delle strade come tappeti; e si muovevano solo al passaggio dell’uomo, comportandosi come l’acqua spinta da una barca: si alzavano in volo, si spostavano di lato per far passare, e ritornavano, subito dopo, nel posto di prima. D’estate, poi, tutti muniti di ventagli, le donne soprattutto: ma era per cacciare le mosche, non per difendersi dal caldo. Nel siciliano di una volta si era soliti dire: “Ah! chissu caccia muşchi”, per intendere che era un perditempo.
Come le mosche, le pulci. Tantissime. Ovunque. Su cani, gatti, topi e sulle persone, senza distinzione di sesso e condizione sociale. Si infilavano nelle pieghe dei vestiti, nei colletti delle camicie, nt’ê pittiğġhi (reggiseni) delle donne, sistemandosi persino nell’ombelico; e quando avevano appetito, un pizzichino appena percettibile che lasciava un cerchietto rotondo e rosato sulla pelle. Dormire con le pulci era normale; alzarsi con una collana di puntini rossi attorno al collo, lo era altrettanto. Per questo, tutti si grattavano, anche in pubblico, come fanno cani e gatti. Sunavănu ’a chitarra, si diceva.
Spulciarsi, soprattutto la sera, prima di andare a letto, era parte di un rito; forma di toeletta che portava gli interessati ad acchiappare l’intrusa pulce, ad arrotolarla delicatamente fra le dita, per schiacciarla con sadica soddisfazione fra le unghie dei due pollici, curando ancora di sentire lo scoppietto, perché in caso contrario era ancora viva. Un indovinello sulla pulce suona così: “Sauta `ca, sauta `đa, fiġğhia‿’i `buttana `chi sauti ca fa”. Nella lingua siciliana, ricca di metafore c’era questo gustoso modo di dire: “A chissi si `mìşcănu ’i puliçi,” per dire che due persone avevano rapporti molto ravvicinati, che offrivano alle pulci l’occasione per cambiare reciprocamente sito e padrone.
Ma, il siciliano di una volta doveva difendersi anche dal pidocchio, altro compagno di viaggio che che si attaccava tenace alla radice dei capelli; ma era lungo il capello, che la pidocchia deponeva in buon ordine la sua covata di uova, dalle quali si schiudevano le microscopiche lendìni (’i línnini). Per questo, nelle tiepide giornate primaverili, le donne si mettevano all'aperto, davanti la porta di casa, per attendere al necessario passatempo: la nonna in piedi spidocchiava la testa della figlia, che spidocchiava a sua volta la figlioletta, o viceversa. L'abilità degli operatori stava nel fare col pettine una scriminatura nei capelli, seguire la linea con lo sguardo vigile per intercettare pidocchi e lendìni, che brillavano al sole come punte di spillo argentate. Gli attrezzi usati per questo compito erano un pettine-stretto, un batufolo di cotone e il micidiale petrolio.
Lotta all’ultimo sangue, anche contro le cimici del letto, acari raccapriccianti che colonizzavano paglia dei materassi, fori lasciati dai tarli nelle tavole del letto, pieghe di cuscini, lenzuola, coperte, ma anche le pareti screpolate della casa, e nei palazzi dei ricchi le pieghe delle carte da parati scollate. Da qui, uscivano di notte, attratte dal profumo inebriante della carne umana. Lì, nel caldo giaciglio, realizzavano la loro orgia di sangue, per ritirarsi sazie alle loro dimore con le prime luci dell’alba. Proprio in virtù delle loro abitudini notturne, le cimici erano difficili da scovare; ma quando se ne intercettava una, si schiacciava, sempre ponendola fra le unghie dei pollici, ben sapendo che si sarebbe vendicata emettendo un odore fetido e nauseabondo.
Ancora una cinquantina d’anni fa, e prima dell’avvento del ddt, le giornate si passavano in compagnia delle mosche, e la sera prima di spegnere il lume o la lampada, si notavano, posate a gruppetti sui fili della corrente elettrica, sui mobili, sulle pareti, che per questo erano tappezzate di puntini neri, con le quali lasciavano il segno del loro passaggio. Si trovavano dappertutto, le mosche. Stabilmente attaccate agli occhi dei bambini, si posavano sugli escrementi animali ovunque presenti; sulle carni esposte nelle macellerie; sulle tavole imbandite dei ricchi e quelle non imbandite dei poveri, e non era raro vedere all’ora di pranzo, schiere di mosche disposte in cerchio sul bordo dei piatti colmi di brodo, a succhiare come idrovore. Ed era normale vedere uno o due di questi insetti cadere in picchiata nel liquido bollente, ora in un piatto ora in un altro, dove rimanevano stecchite e galleggianti, fino a quando un cucchiaio immerso delicatamente in superficie non recuperava il cadaverino per scagliarlo con precisione e disgusto lontano dalla tavola imbandita. Nessuno commentava l’evento, e tutti continuavano a pranzare. Insomma, si conviveva e si mangiava con le mosche. E c’erano mosche, dappertutto, a coprire i muri come carte da parati, i pavimenti delle strade come tappeti; e si muovevano solo al passaggio dell’uomo, comportandosi come l’acqua spinta da una barca: si alzavano in volo, si spostavano di lato per far passare, e ritornavano, subito dopo, nel posto di prima. D’estate, poi, tutti muniti di ventagli, le donne soprattutto: ma era per cacciare le mosche, non per difendersi dal caldo. Nel siciliano di una volta si era soliti dire: “Ah! chissu caccia muşchi”, per intendere che era un perditempo.
Come le mosche, le pulci. Tantissime. Ovunque. Su cani, gatti, topi e sulle persone, senza distinzione di sesso e condizione sociale. Si infilavano nelle pieghe dei vestiti, nei colletti delle camicie, nt’ê pittiğġhi (reggiseni) delle donne, sistemandosi persino nell’ombelico; e quando avevano appetito, un pizzichino appena percettibile che lasciava un cerchietto rotondo e rosato sulla pelle. Dormire con le pulci era normale; alzarsi con una collana di puntini rossi attorno al collo, lo era altrettanto. Per questo, tutti si grattavano, anche in pubblico, come fanno cani e gatti. Sunavănu ’a chitarra, si diceva.
Spulciarsi, soprattutto la sera, prima di andare a letto, era parte di un rito; forma di toeletta che portava gli interessati ad acchiappare l’intrusa pulce, ad arrotolarla delicatamente fra le dita, per schiacciarla con sadica soddisfazione fra le unghie dei due pollici, curando ancora di sentire lo scoppietto, perché in caso contrario era ancora viva. Un indovinello sulla pulce suona così: “Sauta `ca, sauta `đa, fiġğhia‿’i `buttana `chi sauti ca fa”. Nella lingua siciliana, ricca di metafore c’era questo gustoso modo di dire: “A chissi si `mìşcănu ’i puliçi,” per dire che due persone avevano rapporti molto ravvicinati, che offrivano alle pulci l’occasione per cambiare reciprocamente sito e padrone.
Ma, il siciliano di una volta doveva difendersi anche dal pidocchio, altro compagno di viaggio che che si attaccava tenace alla radice dei capelli; ma era lungo il capello, che la pidocchia deponeva in buon ordine la sua covata di uova, dalle quali si schiudevano le microscopiche lendìni (’i línnini). Per questo, nelle tiepide giornate primaverili, le donne si mettevano all'aperto, davanti la porta di casa, per attendere al necessario passatempo: la nonna in piedi spidocchiava la testa della figlia, che spidocchiava a sua volta la figlioletta, o viceversa. L'abilità degli operatori stava nel fare col pettine una scriminatura nei capelli, seguire la linea con lo sguardo vigile per intercettare pidocchi e lendìni, che brillavano al sole come punte di spillo argentate. Gli attrezzi usati per questo compito erano un pettine-stretto, un batufolo di cotone e il micidiale petrolio.
Lotta all’ultimo sangue, anche contro le cimici del letto, acari raccapriccianti che colonizzavano paglia dei materassi, fori lasciati dai tarli nelle tavole del letto, pieghe di cuscini, lenzuola, coperte, ma anche le pareti screpolate della casa, e nei palazzi dei ricchi le pieghe delle carte da parati scollate. Da qui, uscivano di notte, attratte dal profumo inebriante della carne umana. Lì, nel caldo giaciglio, realizzavano la loro orgia di sangue, per ritirarsi sazie alle loro dimore con le prime luci dell’alba. Proprio in virtù delle loro abitudini notturne, le cimici erano difficili da scovare; ma quando se ne intercettava una, si schiacciava, sempre ponendola fra le unghie dei pollici, ben sapendo che si sarebbe vendicata emettendo un odore fetido e nauseabondo.